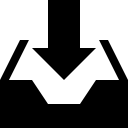ISSN 2385-1376
ISSN 2385-1376Testo massima
Le società in house sono in realtà articolazioni della pubblica amministrazione.
Gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non sono investiti di un mero “munus privato”, ma sono legati alle singole articolazioni della PA da un vero e proprio “rapporto di servizio”, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico.
Tale analogia consente di configurare il danno arrecato dagli amministratori al patrimonio societario, che sia imputabile alla omessa vigilanza degli organi di controllo, come danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.
Svolta decisiva delle Sezioni Unite sulla qualificazione del fenomeno giuridico dell’in house providing.
Dopo la presa di posizione del 22 settembre u.s., da parte della prima sezione civile (sent. n.22209), in favore della fallibilità delle società a partecipazione pubblica, con una netta opzione per le legittime aspettative di tutela dei creditori, la massima composizione della Suprema Corte, chiamata a dirimere un dubbio giurisprudenziale, si è espressa in favore della configurabilità del danno erariale ad opera degli amministratori delle società in questione, sancendo i principi di diritto sopra riportati.
LA VICENDA
Gli amministratori di una società interamente partecipata da un Ente comunale sono stati chiamati, dal Procuratore della Repubblica presso la Sezione del Lazio della Corte dei Conti, a rispondere del danno arrecato alla società, costituita per l’esercizio del trasporto pubblico locale, per aver destinato risorse pubbliche al finanziamento di una non prevista attività di trasporto per conto terzi, remunerando quale mediatrice una diversa società, dalla gestione riconducibile ad alcuni di essi.
Condannati in primo grado, i dirigenti hanno proposto appello alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, che ha dichiarato, accogliendo l’impugnazione, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario , qualificando l’azione come domanda di risarcimento dei danni da mala gestio nei confronti degli organi di una società di diritto privato, ancorché partecipata da soci pubblici.
Sul ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti sono state investite a pronunciarsi le Sezioni Unite, data la coesistenza di controverse interpretazioni sul punto.
LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE
Per addivenire ad una soluzione chiara sul tema della giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori al patrimonio di una società in house, il Supremo Collegio ha dovuto anzitutto soffermarsi sulla qualificazione del fenomeno giuridico in parola, stante la sua derivazione prevalentemente giurisprudenziale (non senza appigli legislativi, in verità, soprattutto nella normativa sui servizi pubblici locali) e la sua collocazione “borderline”, considerata l’ibridazione tra caratteristiche (e struttura di base) di stampo privatistico e finalità (e relative forme di controllo) di ordine pubblicistico.
Nel caso di specie, viene posta fuori dal campo di analisi delle SS.UU. la preliminare qualificazione della società danneggiata quale società “in house”, stante la valutazione compiutamente operata sui fatti di causa dal Giudice di primo grado e non oggetto di contestazione nell’impugnazione ad opera dei soggetti soccombenti.
Giova rammentare che il fenomeno delle società in house, come chiarito nella sentenza in esame, trova pieno sviluppo dopo l’entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che lascia liberi gli Stati di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d’interesse economico generale, potendo essi scegliere tra tre fondamentali opzioni:
1. fornitura diretta;
2. affidamento in gestione a soggetti terzi;
3. affidamento a società partecipate, in tutto (queste, appunto, le società “in house”) o in parte, dall’ente pubblico medesimo.
Nel caso di società interamente partecipate dall’ente pubblico, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza “Teckal” del 18.11.1999, ha sancito che non è necessario che l’affidamento dei servizi avvenga tramite le procedure di evidenza pubblica, stante l’insussistenza di esigenze di tutela della concorrenza.
Attraverso l’analisi congiunta dei precedenti giurisprudenziali e della normativa interna (in particolare l’art.113, comma 4 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le Sezioni Unite hanno enucleato e specificato i connotati che una società deve congiuntamente presentare perché possa ascriversi al genus dell’in house providing.
In primis, i soci devono avere tutti natura esclusivamente pubblica, con la conseguenza che essi possono essere anche una pluralità di enti pubblici, ma purché lo statuto non preveda la cedibilità a privati delle partecipazioni di cui essi siano titolari.
In secondo luogo, l’attività dev’essere esercitata “prevalentemente” a favore dei soci (pubblici) stessi. Al riguardo viene precisato che la prevalenza non va valutata solo da un punto di vista “quantitativo”. Occorre, inoltre, che le eventuali attività accessorie, non direttamente destinate a favore dei soci, siano comunque marginali e strettamente “strumentali” rispetto all’attività principale.
Ancora, viene richiamato il principio del c.d. “controllo analogo”. Vale a dire che l’ente pubblico partecipante deve avere statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, in maniera non dissimile da quanto accade nel caso della gestione diretta dei servizi, nonché con modalità di controllo analoghe.
CONNOTATI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE
|
|
1. Natura esclusivamente pubblica dei soci
|
|
2. Esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci
|
|
3. Sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello
|
Alla luce dei criteri di individuazione suindicati, risulta chiara l’anomalia delle società in questione, le quali, strutturate come società di capitali, operano fuori dal mercato e senza un reale potere decisionale autonomo.
Tale caratteristica è, sì, riscontrabile in parte nel fenomeno dei gruppi societari, dove vi è una sorta di “eterodirezione” delle società controllate. Tuttavia, sottolinea la Corte, queste ultime non perdono mai del tutto la loro autonomia “gestionale”.
Quanto al punto che qui interessa, le Sezioni Unite ricostruiscono anzitutto i casi in cui può dirsi certamente sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, individuandoli in quelle situazioni in cui, o è la legge, ai sensi dell’art.103, comma 2 Cost. ad affidare determinate controversie al giudice contabile, ovvero possa comunque configurarsi un danno “diretto” (e non “riflesso”) al patrimonio dell’ente pubblico, anche se cagionato dall’azione illegittima di soggetti formalmente non inseriti organicamente nell’ente medesimo.
Orbene, nella precedente giurisprudenza richiamata dalla Corte, è affermato come principio generale che le società di capitali eventualmente costituite o partecipate dalla pubblica amministrazione non cessano, per questo, di essere società di diritto privato, con la conseguenza che trovano la loro disciplina nelle norme del codice civile, anche ai sensi dell’art.2449 del codice stesso.
Ne consegue che il danno arrecato eventualmente al patrimonio della società dalla mala gestio degli amministratori è, come tale, risarcibile attraverso la comune azione di responsabilità promossa dai soci o dai creditori sociali e non rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Tuttavia, alla luce delle peculiarità della società in house, e soprattutto in virtù del già richiamato raffronto con il fenomeno dei gruppi societari, le Sezioni Unite giungono alla tranciante affermazione secondo la quale queste non paiono in grado di collocarsi come entità poste al di fuori dell’ente pubblico, che ne dispone come sue articolazioni interne.
Di fatto, esse non sono che una longa manus della pubblica amministrazione, di tal che l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa.
Tale ultimo principio, già sancito da una precedente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, conduce ad affermare che “il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”.
Il termine società, qui adoperato, sta solo a significare che, ove manchino specifiche norme contrarie, “il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario”, ma non può più parlarsi di società come persona giuridica autonoma, cui corrisponda un autonomo potere decisionale ed un autonomo interesse.
Se le società sono, in realtà, articolazioni interne della pubblica amministrazione, ne discende il vincolo gerarchico cui sono sottoposti gli organi della società nei confronti della pubblica amministrazione.
Dunque, i soggetti che, pro tempore, rappresentano quegli organi, non sono investiti di un mero munus privato, ma sono legati alla PA da un vero e proprio rapporto di servizio.
L’affermazione, dalla grande portata innovativa, deriva evidentemente dal fatto che due situazioni sostanzialmente analoghe (quella dei dirigenti pubblici e quella degli amministratori delle società in house) non possono essere trattate giuridicamente in maniera diversa.
Se sussiste un “rapporto di servizio”, si configura anche un potere di controllo da parte dell’ente pubblico. Di conseguenza, ove colpevolmente tale controllo sia deficitario, il danno arrecato dagli amministratori della società al patrimonio di quest’ultima è in realtà danno arrecato ad un patrimonio riconducibile allo stesso ente pubblico. Ciò anche perché “se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità”.
Onde la qualificazione del predetto danno quale danno “erariale”, con la conseguente attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO
Concludendo con l’affermazione di un principio tanto importante quanto innovativo, le Sezioni Unite cassano la sentenza d’appello, enunciando il principio di diritto, che qui testualmente si riporta: “la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sez. –
Dott. RORDORF Renato – rel. Presidente Sez. –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28495/2012 proposto da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
– ricorrente –
contro
L.M.F.,;
R.S.A.;
STUDIO LEGALE T.;
– controricorrenti –
e contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 631/2012 della CORTE DEI CONTI – 3^ Sezione giurisdizionale centrale – ROMA, depositata l’11/10/2012;
Svolgimento del processo
Il 9 marzo 2009 il Procuratore della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti citò in giudizio dinanzi a detta sezione i sigg.ri R.S.A., C.A. e L.M.F., i quali avevano rispettivamente ricoperto le cariche di direttore generale, sindaco ed amministratore unico di una società interamente partecipata dal Comune di (OMISSIS), denominata ALFA. Il Procuratore lamentò che i convenuti, nell’espletamento delle rispettive funzioni, avessero arrecato danno alla società, costituita per l’esercizio del trasporto pubblico locale, impegnandone le risorse in una non prevista attività di trasporto merci per conto terzi e remunerando per mansioni mediatorie, in realtà non effettuate, una diversa società costituita dal sig. C. e gestita di fatto dal sig. R..
L’adito giudice contabile, con sentenza del 4 maggio 2010, accolse le domande del Procuratore e condannò i convenuti a risarcire il danno sofferto dalla ALFA. Fu proposto appello e la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza depositata l’11 ottobre 2012, avendo ritenuto che l’azione per risarcimento dei danni da mala gestio nei confronti degli organi di una società di diritto privato, ancorchè partecipata da soci pubblici, rientri nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario, riformò la decisione di primo grado e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, formulando due motivi di doglianza entrambi volti ad affermare la sussistenza, nel caso in esame, della giurisdizione del giudice contabile.
I sigg.ri R. e L. hanno resistito con distinti controricorsi. Il sig. L. ha anche depositato una successiva memoria. Nessuna difesa ha svolto invece in questa sede il sig. C..
Motivi della decisione
1. Le sezioni unite sono nuovamente chiamate a stabilire se sussista, ed eventualmente entro quali limiti, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti che abbiano svolto funzioni amministrative o di controllo in società di capitali (nella specie una società per azioni) costituite e partecipate da enti pubblici, quando a quei soggetti vengano imputati atti contrari ai loro doveri d’ufficio con conseguenti danni per la società.
Su tale questione, come più diffusamente si dirà tra un momento, questa corte è già intervenuta negli ultimi anni con molteplici pronunce. Conviene dire subito, però, che la fattispecie ora in esame presenta una connotazione particolare, cui solo di sfuggita v’era stata occasione di far cenno in alcune precedenti occasioni:
cioè che la società asseritamente danneggiata dai propri gestori ed organi di controllo presenta le caratteristiche di una cosiddetta società in house.
Cosa con tale espressione debba intendersi e perché ciò rilevi ai fini della giurisdizione lo si chiarirà meglio in seguito. Qui giova sottolineare che la qualifica della ALFA come società in house del Comune di (OMISSIS) discende da un accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, il quale ne ha dato dettagliatamente atto nella propria sentenza (si vedano, in particolare, le pagg. 9 e 10), nella quale è infatti puntualizzato: che l’anzidetta società è stata costituita dall’ente pubblico comunale, il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; che essa ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio degli ausiliari della sosta e quello dei parcheggi); che la parte più importante dell’attività sociale è svolta in favore del comune partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
A tali accertamenti non risulta siano state mosse contestazioni specifiche negli atti di gravame proposti dagli interessati contro la sentenza di primo grado, nè il giudice d’appello li ha rimessi in discussione, in punto di fatto, sicché (pur non risultando possibile in questa sede l’esame diretto dello statuto della società ALFA, non prodotto agli atti del giudizio di cassazione) si può tenere senz’altro per fermo che la società di cui si discute presenta le caratteristiche sopra riferite.
2. Si è già ricordato all’inizio come sul tema della giurisdizione contabile in materia di responsabilità di gestori ed organi di controllo delle società partecipate da enti pubblici le sezioni unite di questa corte si siano già ripetutamente espresse, sin da quando ha cominciato ad avere grande diffusione il fenomeno dell’uso dello strumento societario privato da parte delle pubbliche amministrazioni anche per la realizzazione di finalità tipicamente pubblicistiche, e poi con crescente frequenza negli ultimi anni.
Sarebbe inutile ripercorrere qui le diverse tappe di questo iter giurisprudenziale, al quale ovviamente anche la dottrina ha dato il suo apporto critico, pur manifestando posizioni talora alquanto divaricate. Converrà solo richiamare brevemente i punti salienti dell’orientamento da ultimo consolidatosi, diffusamente esposti nella sentenza n. 26806 del 2009 (alla quale anche la giurisprudenza successiva si è allineata quasi senza eccezioni: si vedano, ad esempio, Sez. un. 10299/13, 7374/13, 20940/11, 20941/11, 14957/11, 14655/11, 16286/10, 8429/10, e 519/10).
2.1. Premesso che l’art. 103 Cost., comma 2, impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge (rinvenibile all’origine nella previsione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni, con il successivo ampliamento dovuto alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, che ha esteso il giudizio della stessa Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza), la richiamata pronuncia delle sezioni unite muove da un duplice rilievo: anzitutto che nell’attuale assetto normativo il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione si realizza anche mediante attività disciplinate in tutto o in parte dal diritto privato, onde il dato essenziale che radica la giurisdizione della corte contabile è rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico della stessa pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; in secondo luogo, che le società di capitali eventualmente costituite o comunque partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano sol per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina, se non diversamente disposto, riposa tuttora sulle norme dettate dal codice civile, come confermato anche dal dettato dell’art. 2449 dello stesso codice (nella cui relazione accompagnatoria è detto infatti espressamente che “è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”).
In ossequio ad un principio comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci, ed è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di partecipazione. Pertanto, non solo risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, ma soprattutto non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di mala gestio, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società.
La responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere che grava sugli organi sociali, assoggettati alle medesime norme sia quando designati dai soci secondo le regole generali dettate in proposito dal codice sia quando eventualmente designati dal socio pubblico in forza dei particolari poteri a lui spettanti (art. 2449 cit., comma 2), opera quindi sempre nei termini stabiliti dall’art. 2392 c.c. e segg., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata.
Di conseguenza il danno cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all’azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un’ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perché non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci – pubblici o privati – i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo. E l’esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell’impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l’ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l’esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile.
Risulta viceversa configurabile l’azione del procuratore contabile quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall’ente pubblico che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente. Si è allora innegabilmente in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall’agente al patrimonio dell’ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all’immagine della pubblica amministrazione, la cui riconducibilità entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal disposto della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 ter, (quale risulta dopo le modifiche apportate dal d.l. in pari data, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni nella L. 3 ottobre 2009, n. 141). E’ in questo quadro di principi generali che deve essere perciò letta anche la disposizione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis, (che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società quotate un’eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile.
L’azione del procuratore contabile appare poi anche configurabile nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione.
3. Il collegio è persuaso che l’orientamento ora richiamato, ispirato dall’esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale, debba essere in via generale tenuto fermo, anche alla luce della normativa sopravvenuta. Normativa alla quale il carattere spesso frammentario e l’esser frutto di esigenze contingenti impediscono di assumere una valenza sistematica, che vada oltre il dettato della singola disposizione, onde parrebbe quanto mai azzardato il voler trarre da essa argomenti di ordine generale, tali da incidere sui principi giuridici su cui è basata la citata giurisprudenza di questa corte in materia, o anche solo indici dell’esistenza di principi in tutto o in parte diversi da quelli. La disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche – come anche la più attenta dottrina non ha mancato di rilevare – non ha tuttora assunto le caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sé stante, ma continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione.
Ciò dicasi, in particolare, per l’inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero delle amministrazioni pubbliche cui si estende l’opera di supervisione, monitoraggio e coordinamento nell’approvvigionamento di beni e servizi, demandata al commissario straordinario nominato dal Governo a norma del D.L. 7 maggio 2010, n. 52, art. 2, (convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94), inclusione ovviamente ispirata dall’esigenza di evitare aggravamenti anche solo indiretti della spesa pubblica, ma che non consente certo sol per questo di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica cui detta norma si riferisce; e lo stesso dicasi per l’assoggettamento delle società partecipate a vincoli economici derivanti dal c.d. patto di stabilità e per i conseguenti maggiori controlli, da parte degli enti pubblici partecipanti, a tal fine imposti dall’art. 147 quater del testo unico sugli enti locali (articolo introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).
Analogamente le disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), nel dettare regole particolari in tema di nomina e di compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, non si discostano dalla logica da cui è già ispirato il citato art. 2449 c.c. – che s’è visto essere coerente con l’inquadramento generale di tali enti, per tutto il resto, nel novero delle società azionarie soggette alla disciplina privatistica – ed, anzi, il comma 13 del medesimo art. 4 ribadisce espressamente che, “per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. Il che dimostra con evidenza come non possa essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata di tale disposizione eccezionale, neppure alla previsione del precedente comma 12, per la quale gli amministratori ed i dirigenti delle anzidette società, in caso di violazione dei vincoli di spesa stabiliti dai commi precedenti, “rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contrati stipulati”.
Né in virtù di tali disposizioni, né di altre altrettanto frammentarie e disorganiche che sono sparse nell’ordinamento e delle quali sarebbe qui superfluo dare dettagliatamente conto, è dato insomma sottrarsi alla drastica alternativa già precedentemente segnalata: alternativa per la quale, fin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, e quindi tra la distinta titolarità dei rispettivi patrimoni, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato – previsione certo possibile, ma che allo stato non appare individuabile in termini generali nell’ordinamento – ; oppure sull’attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico, onde il danno arrecato al suo patrimonio potrebbe qualificarsi senz’altro come danno erariale. Soluzione, quest’ultima, che appare però ben difficilmente predicabile, perché trova un solido ostacolo nel disposto della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l’intervento del legislatore per l’istituzione di un ente pubblico; e pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente. Di modo che, se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco. Ma, quanto alle società a partecipazione pubblica, lungi dal ravvisarsi disposizioni normative che inequivocabilmente attribuiscano loro la qualifica di ente pubblico, s’è già visto come il legislatore si sia preoccupato a più riprese di ribadirne, in via generale e fatta salva l’applicazione di singole regole speciali, l’assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato, con le già richiamate conseguenze in punto di riparto di giurisdizione (solo in presenza di società di fonte legale, regolate da una disciplina sui generis di chiara impronta pubblicistica, quale ad esempio la Rai, è parso necessario pervenire a conclusioni diverse: si vedano Sez. un. 22 dicembre 2009, n. 27092).
4. Nelle considerazioni ora svolte assume un ruolo centrale, come s’è già sottolineato, la distinzione tra la società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorché eventualmente pubblici). Distinzione che – è appena il caso di ricordarlo – in via di principio non vien meno neppure nell’eventualità in cui la società sia unipersonale ed il capitale sociale appartenga quindi ad un unico socio, in base alle regole di matrice comunitaria introdotte nel nostro ordinamento prima per le sole società a responsabilità limitata e poi anche per le società azionarie.
E’ proprio partendo da questo profilo che si manifesta, però, la necessità di un’ulteriore riflessione quando ci si trovi in presenza di quel particolare fenomeno giuridico, al quale si è già dovuto far cenno all’inizio di questa sentenza, che ha trovato ampia diffusione negli ultimi decenni e che va sotto il nome di in house providing.
4.1. La direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d’interesse economico generale (art. 1, par. 6). È perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest’ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso il l’affidamento a società partecipate dall’ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l’affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l’affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l’affidamento a società c.d. in house. Solo in quest’ultimo caso la Corte di Giustizia Europea (sin dalla nota sentenza Teckal del 18 novembre 1999, n. 107/98) ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall’ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell’ente sui propri stessi uffici. Siffatte indicazioni sono state pienamente recepite, in ambito nazionale, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano tra le tante, a mero titolo d’esempio, le pronunce n. 7636/04, 962/06, 1513/07, 2765/09, 5808/09, 7092/10 ed 1447/11), sia da ultimo dalla Corte dei conti (si veda la sentenza n. 546/13). Anche queste stesse sezioni unite hanno avuto occasione, sia pur fuggevolmente, di farvi recentemente riferimento (si vedano le ordinanze del 5 aprile 2013, n. 8352, e del 3 maggio 2013, n. 10299) se ne è occupata più volte, infine, la Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza 20 marzo 2013, n. 46, sulla quale si dovrà poi brevemente tornare).
Pur trattandosi all’origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società in house non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perché tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell’art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti a locali (D.Lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l’affidamento di servizi pubblici, anziché ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purché esse realizzino la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che le controllano e purché questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
E’ dunque possibile considerare ormai ben delineati nell’ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s’intende che, per poter parlare di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.
4.2. Poche brevi osservazioni paiono ancora opportune per meglio puntualizzare le tre caratteristiche salienti della società in house.
In ordine alla prima di esse giova ricordare come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purché si tratti sempre di enti pubblici (si vedano le sentenze della Corte di giustizia 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant), e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato (si vedano, tre le altre, le pronunce n. 7092/10 ed 8970/09). E’ quasi superfluo aggiungere che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.
Il requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439 (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva – e segnatamente per quel che interessa ciò che si andrà a dire in ordine alla reale natura delle società in house ai fini del riparto di giurisdizione – quel che soprattutto importa è che l’eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d’interesse economico generale svolto dalla società in via principale.
Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.
L’espressione “controllo” non allude perciò, in questo caso, all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita).
4.3. Le caratteristiche ora sommariamente descritte – e soprattutto la terza – bastano a rendere evidente l’anomalia del fenomeno dell’in house nel panorama del diritto societario.
E’ già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale.
Si potrebbe obiettare che il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto societario, e che anzi, dopo la riforma attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003, esso ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 2497 c.c. e segg.. Ma non è la stessa cosa. Nei gruppi societari il potere di direzione e coordinamento spettante all’ente capogruppo attiene all’individuazione delle linee strategiche dell’attività d’impresa senza mai annullare del tutto l’autonomia gestionale della società controllata. Gli amministratori di quest’ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacché, pur con gli adattamenti resi necessari dall’esser parte di un gruppo imprenditoriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell’art. 2380 bis c.c., comma 1) né, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l’interesse della stessa società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime.
La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dai citato art. 2497 e segg., insomma, è volta a coniugare l’unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque entità giuridiche e centri d’interesse distinti l’una dalle altre. Altrettanto non sembra potersi dire invece per la società in house, sia per la già ricordata subordinazione dei suoi gestori all’ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l’impossibilità stessa d’individuare nella società un centro d’interessi davvero distinto rispetto all’ente pubblico che la ha costituita e per il quale essa opera.
Allo stesso modo, ove si abbia a che fare con una società a responsabilità limitata, non sembra possibile ricondurre sic et simpliciter il “controllo analogo”, caratteristico del fenomeno dell’in house, ad uno dei “particolari diritti riguardanti l’amministrazione” che l’atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacché neppure siffatti diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest’ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il suo primario dovere di perseguire l’interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di autonomia rispetto a quello personale del socio.
La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talché “l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.).
Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.
L’uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare.
5. Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui questa corte è pervenuta nell’individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali le si è esposte nei paragrafi 2 e 3 della presente sentenza, anche quando si tratti di società in house.
Non possono valere perché – ciò sia detto quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione – queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s’è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.
Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico.
L’analogia tra le due situazioni, che si è visto essere una delle caratteristiche salienti del fenomeno dell’in house, non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, né quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione.
D’altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.
Dal che discende che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico:
è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.
6. Il ricorso deve quindi esser accolto, in base al principio di diritto qui di seguito enunciato: “La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte dei conti per un nuovo giudizio.
PQM
La corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, dichiarando che la Corte dei conti ha giurisdizione sulla presente causa, che rinvia alla medesima Corte dei conti.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 677/2013